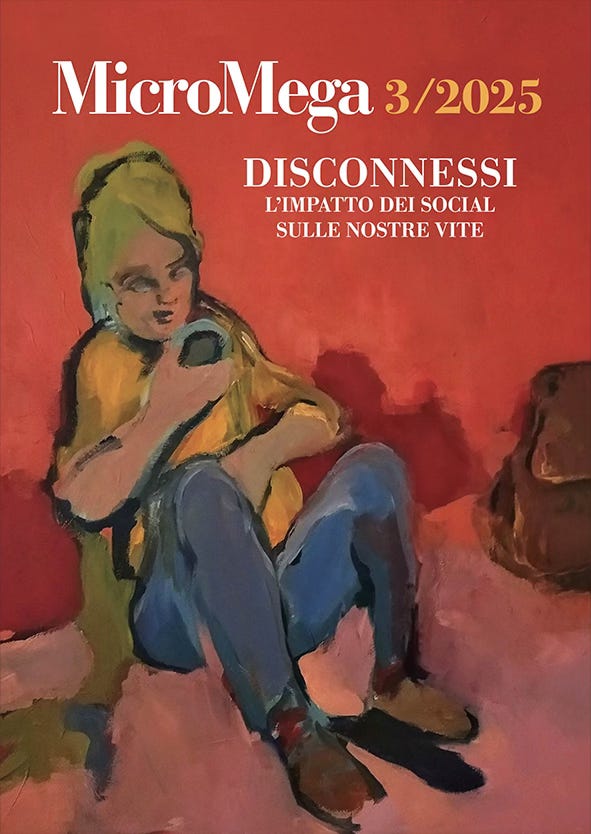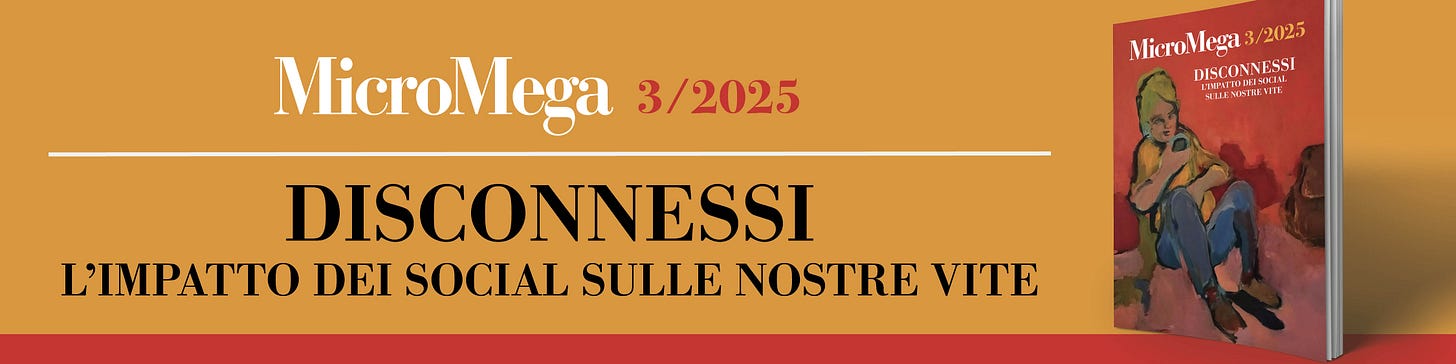Social media: una questione politica
Leggi il prologo della direttrice al volume "Disconnessi. L'impatto dei social sulle nostre vite".
Il prologo di Cinzia Sciuto
Che ci fosse un legame tra il potere politico e il potere delle piattaforme digitali lo sapevamo già. Ma con la vittoria di Trump e l’ingresso di Elon Musk nel governo degli Stati Uniti il cortocircuito è esploso in tutta la sua evidenza. La profonda commistione tra potere politico e potere infrastrutturale è emersa nella sua forma più eclatante: la piattaforma che si fa governo, l’oligarca digitale che smantella pezzo dopo pezzo la macchina amministrativa pubblica. Il re è nudo.
E con i meccanismi di potere che stanno dietro le piattaforme – meccanismi vecchi quanto il mondo, pur nelle forme ipermoderne dell’immateriale – vengono svelate anche le logiche e le dinamiche che governano le piattaforme, con effetti di gran lunga più pervasivi e profondi di quello che immaginavamo su tutti gli ambiti della nostra vita, e persino al di là dell’uso personale che ciascuno ne fa.
Negli ultimi anni ci eravamo illusi che l’accesso immediato e disintermediato alla parola pubblica fosse sinonimo di libertà di pensiero e di espressione. Ma quella che sembrava una conquista democratica senza precedenti (e che in potenza forse lo era davvero) sta mutando, paradossalmente, in una nuova forma di assoggettamento, creando l’illusione che basti un account e qualche post per essere parte attiva della discussione pubblica. E invece, senza strumenti critici, senza competenze, senza consapevolezza delle logiche che regolano quegli spazi, finiamo per essere non soggetti della parola pubblica, ma oggetti delle dinamiche più opache che governano le piattaforme.
È il paradosso di molte tecnologie moderne: la sempre maggiore facilità d’uso va di pari passo con la sempre maggiore complessità dei loro meccanismi di funzionamento. Chi utilizzava una macchina da scrivere aveva certamente anche le competenze necessarie per capirne il funzionamento. Oggi possiamo utilizzare complicatissimi software di Intelligenza Artificiale senza avere la minima idea della logica e dei meccanismi che li governano. L’estrema facilità d’uso e di accesso ha portato al collasso della mediazione: tra chi produce un messaggio e chi lo riceve, tra ciò che accade nel mondo e ciò che viene raccontato, tra il desiderio e la sua realizzazione. Un tempo, tra il sogno di cantare a Sanremo e il palco dell’Ariston, c’erano anni di studio, prove, fallimenti. Oggi, con un video postato su TikTok si può realizzare im-mediatamente un sogno. O almeno averne l’illusione, che sempre più spesso funge da surrogato alla soddisfazione del sogno. E in quello spazio-tempo collassato si perde la possibilità di costruire competenze, rafforzare desideri, maturare. Il risultato? Una fragilità diffusa, un’incapacità crescente di affrontare la frustrazione, il fallimento, la complessità, il confronto dialettico.
Questo volume si muove lungo due assi principali: da un lato, l’impatto dei social sulla politica e sul dibattito pubblico; dall’altro, le trasformazioni che essi imprimono sulle nostre vite, sulle nostre relazioni, su chi siamo. I social non sono più – se mai lo sono stati – strumenti neutri. Sono dispositivi potentissimi che modellano le nostre identità, il nostro linguaggio, il nostro modo di stare al mondo e di relazionarci con noi stessi – le nostre emozioni, i nostri desideri, le nostre aspirazioni – e con gli altri. E lo fanno in modo sempre meno orizzontale e sempre più verticistico: nelle mani di pochi e al servizio di chi ha le risorse per piegarne le logiche algoritmiche ai propri scopi, come i movimenti di estrema destra in tutto il mondo.
Come sempre, MicroMega non adotta uno sguardo apocalittico né dogmatico. Non invitiamo all’esodo digitale, perché non ci crogioliamo nell’illusione che la fuga (che pure in molti stanno sperimentando) risolva il problema. Quello che proponiamo è uno sforzo critico. Offrire strumenti per comprendere, per smontare, per interrogare il modo in cui queste piattaforme operano: non nei loro dettagli tecnici, ma nei loro effetti politici, culturali, sociali. Con un’avvertenza importante: non è (solo) responsabilità del singolo. È una questione politica. Di assetti economici, di scelte collettive, di strutture materiali. Rendere i social luoghi più trasparenti, meno manipolatori, più democratici, è compito della società nel suo insieme. A partire da un intervento radicale su ciò che li regge: il loro modello di business, il loro potere infrastrutturale, la loro opacità. Solo così potremo davvero immaginare una sfera pubblica che torni a essere, se non una piazza accogliente, almeno un luogo frequentabile.
ACQUISTA LA TUA COPIA NELLA TUA LIBRERIA DI FIDUCIA O NEI PRINCIPALI STORE.
OPPURE ABBONATI PER RICEVERLO DIRETTAMENTE A CASA O LEGGERLO IN DIGITALE.
Con contributi di: Daniel Miller, Jonathan Haidt, Candice Odgers, Marco Deseriis, Francesco Brusa, Vito Saccomandi, Christian Elia, Paolo Gerbaudo, Gloria Origgi, Emma Catherine Gainsforth, Andrea Daniele Signorelli, Pierfranco Pellizzetti, Serena Ciranna, Fabio Bartoli, Stefana Broadbent, Nicola Grandi, Mariasole Garacci, Paolo Ercolani, Elettra Santori, Bianca Arrighini, Francesco Cancellato e Gianmichele Laino.